Prima che BioWare concludesse la saga originale di Mass Effect, prima dei racconti emozionali e disperanti di DONTNOD e Telltale Games, ci fu Infocom, software house nata in seno al MIT, il prestigioso Massachusetts Institute of Technology. I suoi membri fondatori, Marc Blank e Dave Lebling, autori dell’epica fantasy che risponde al nome di Zork, condividevano una visione comune a molti programmatori di quell’epoca che potremmo definire pionieristica: creare e commercializzare i propri titoli; nello specifico, opere di narrativa interattiva o giochi “interlogici”, come venivano chiamati agli esordi.
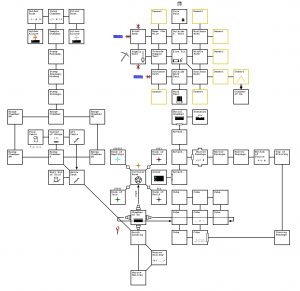 Forti dei primi successi, gli implementatori si resero presto conto della incredibile versatilità dell’interprete realizzato, consapevolezza che li portò a intuire il potenziale che avevano tra le mani, ovvero la possibilità di elevare il medium: in pratica, l’opportunità di raccontare storie al giocatore, vicende in grado di muoverlo al di là della banale logica dell’accumulo di un punteggio – 19 sono i tesori da collezionare nel primo Zork – e della competizione, perché il nostro score in sala giochi, è inutile negarlo, è sempre stato motivo di grande vanteria. Alla scuderia vennero quindi affiliati “cavalli” di razza, fra cui Steve Meretzky, autore di Planetfall, e Michael Berlyn, responsabile del criticatissimo Infidel. E se il primo titolo mira a commuoverci introducendo Floyd, una spalla robotica a cui sarebbe saggio NON affezionarsi troppo, è con l’opera del secondo che ha inizio la decennale diatriba fra chi sostiene che l’autore debba godere di assoluta libertà artistica e chi, invece, ritiene che questi debba tener conto, sempre e comunque, della soddisfazione personale del giocatore. Infidel (1983) narra la vicenda di un sedicente archeologo, à la Indiana Jones, se vogliamo, alle prese con la ricerca di un favoloso tesoro tumulato in una perduta piramide.
Forti dei primi successi, gli implementatori si resero presto conto della incredibile versatilità dell’interprete realizzato, consapevolezza che li portò a intuire il potenziale che avevano tra le mani, ovvero la possibilità di elevare il medium: in pratica, l’opportunità di raccontare storie al giocatore, vicende in grado di muoverlo al di là della banale logica dell’accumulo di un punteggio – 19 sono i tesori da collezionare nel primo Zork – e della competizione, perché il nostro score in sala giochi, è inutile negarlo, è sempre stato motivo di grande vanteria. Alla scuderia vennero quindi affiliati “cavalli” di razza, fra cui Steve Meretzky, autore di Planetfall, e Michael Berlyn, responsabile del criticatissimo Infidel. E se il primo titolo mira a commuoverci introducendo Floyd, una spalla robotica a cui sarebbe saggio NON affezionarsi troppo, è con l’opera del secondo che ha inizio la decennale diatriba fra chi sostiene che l’autore debba godere di assoluta libertà artistica e chi, invece, ritiene che questi debba tener conto, sempre e comunque, della soddisfazione personale del giocatore. Infidel (1983) narra la vicenda di un sedicente archeologo, à la Indiana Jones, se vogliamo, alle prese con la ricerca di un favoloso tesoro tumulato in una perduta piramide. 
diatriba fra chi sostiene che l’autore debba godere di assoluta libertà artistica e chi ritiene che questi debba tener conto della soddisfazione personale del giocatore
D’altronde, i tempi sono quelli della mitica trilogia del professore con la frusta, a cavallo tra I Predatori dell’Arca Perduta, 1981, e Il Tempio Maledetto, 1984. Il quadro dipinto dall’avventura – fra delirante corrispondenza e descrizioni asciutte come la rovente sabbia del deserto – non lascia adito a dubbi:
l’avatar di cui vestiamo i panni è un avido arruffone. Non c’è dunque da stupirsi che, a tesoro ritrovato, il gioco ci “ricompensi” con queste crude righe: “Apri il coperchio con gran cura, e in un istante vedi realizzarsi tutti i tuoi sogni. L’interno del sarcofago è foderato d’oro, ricolmo di gioielli che scintillano alla luce della torcia. … La camera funeraria sta collassando, i muri crollando. Non uscirai mai vivo da questa piramide. Ti sei meritato questo tesoro, ma ti è costato la vita. … Se qualcuno si fosse trovato dall’altra parte del muro, che collassa rapidissimo, avrebbe potuto trarti in salvo. Se solo avessi trattato meglio i tuoi lavoratori. Se solo avessi condiviso il tuo ritrovamento con Craige. Se solo avessi assunto una guida affidabile. Beh, un giorno qualcuno scoprirà le tue ossa e così otterrai la fama che hai sempre ambito”.
Così chiosando, Infidel imbastisce una piccola morale sui “benefici” portati dall’avidità, veicolando il punto di vista dell’autore. Naturalmente, affermare che questo finale fu divisivo è dir poco, con la community che si scisse fra chi plaudì il coraggio dello sviluppatore americano e chi lo criticò aspramente. E se le lodi si spiegano da sé, dacché il medium aveva trovato nuovi fiati, il punto di vista dei delusi trova giustificazione nella semplice considerazione che non importa quanto siano elaborati i panni dell’avatar che siamo chiamati a interpretare: sotto vestimenti finemente intessuti o un lurido canovaccio si trova sempre il giocatore che si arrabatta – per risolvere puzzle, eliminare avversari, mappare gli ambienti di gioco – e che si sente privato di una “giusta” ricompensa. Chiaramente, questo fu l’inizio, una sorta di finale stile Mass Effect 3 ante litteram. Da allora, si sono affastellati pregevolissimi esempi di narrazioni “maledette”, che portano a conclusioni marcatamente tragiche, e di giochi che presentano scelte chiaroscuro che siamo chiamati a compiere e che recano al cospetto di finali multipli, con il bad ending che se ne sta sempre lì, in agguato, come un ombroso Grue, pronto a guastarci la festa o a stupirci “positivamente”, perché non solo di “… e vissero per sempre felici e contenti” possiamo nutrirci.
per certi titoli un finale amaro è l’unica conclusione disponibile
In questo che vuole anche essere un breve vademecum, vorrei citare
Gabriel Knight: Sins of the Fathers (1993), laddove un ultimo gesto di pietà porta logicamente alla conclusione lieta, o meno drammatica, mentre un atto finale di egoismo condanna il protagonista a una sorte invero orrenda. Da tradizione, la serie di
Myst (1993-2005) offre sempre un bivio decisivo con l’appressarsi della conclusione, con una delle due strade che porta diritta nel vicolo scuro del bad ending. Tuttavia,
se nei due casi sopraccitati basta un minimo di discernimento per evitare il “finale cattivo”, per certi titoli un epilogo amaro è invece l’unica conclusione disponibile. Non lascia speranze, dunque,
Black Dahlia (1998), un tour de force di puzzle astrusissimi spalmati su 8 CD e che vanta attori del calibro di Dennis Hopper e Teri Garr. L’opera in FMV di
Take Two Interactive ci riserva una “ricompensa” particolarmente cruda a fine impresa, qualora riuscissimo a salvare il mondo dall’ennesimo complotto nazistaTM, “vanificando” ore e ore di meningi spremute. Parimenti, non dà scampo
Planescape: Torment (1999), ma su questo il titolo di
Black Isle è onestissimo, giacché una volta ascoltate e metabolizzate le parole di Deionarra il nostro destino ci appare subito chiaro nonché ineluttabile. Nel caso specifico sono presenti varie sfumature di bad ending: il migliore è quello che ci concede di congedarci in maniera soddisfacente con gli ottimi companion. E nemmeno
Alan Wake (2010) finisce su note propriamente liete, anche se, date le molteplici chiavi di lettura del capolavoro di
Remedy, tutto rimane aperto a possibile interpretazione… o sequel!

mi pare vi sia oggi una sovrabbondanza di titoli story-driven votati esclusivamente al dramma
Il grande Peppino De Filippo sosteneva che “
Fare piangere è meno difficile che far ridere”, e infatti mi pare vi sia oggi una sovrabbondanza di titoli story-driven votati esclusivamente al dramma, quando un titolo come
Tales from the Borderlands (2014-2015), non scevro di amari momenti,
ci mostra come sia possibile creare una storia di altissimo profilo e character di profondissimo spessore, senza per questo dover imbastire una tragedia di proporzioni shakespeariane o rinunciare a un buon, vecchio lieto fine. In ogni caso, alla luce degli esempi fatti, debbo dirvi che
personalmente ho imparato a convivere col NON lieto fine e – talvolta – ad apprezzarlo, soprattutto quando è componente inscindibile del narrato, perché sarebbe impossibile immaginare
Life is Strange (2015) con un finale lieto in assoluto. Quando invece mi coglie di sorpresa, o ravviso in esso la volontà di drammatizzare un gioco che pareva partito con altre premesse, il sangue si fa acido; soprattutto,
storco il naso di fronte a quei titoli così ricchi di scelte, dove un claim ci ricorda sovente che siamo noi a modellare la storia e che il destino dei protagonisti è nelle nostre mani…
salvo non poter incidere proprio sul momento topico, ovvero la conclusione. O forse, quando resto perplesso è per via di quell’ottica old school che mi porto appresso da
The Secret of Monkey Island, perché ancora sono legato alla logica dello zuccherino a mo’ di ricompensa.
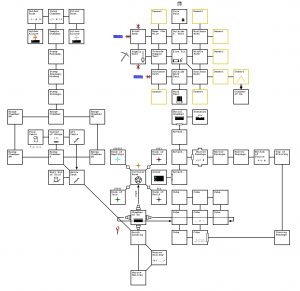 Forti dei primi successi, gli implementatori si resero presto conto della incredibile versatilità dell’interprete realizzato, consapevolezza che li portò a intuire il potenziale che avevano tra le mani, ovvero la possibilità di elevare il medium: in pratica, l’opportunità di raccontare storie al giocatore, vicende in grado di muoverlo al di là della banale logica dell’accumulo di un punteggio – 19 sono i tesori da collezionare nel primo Zork – e della competizione, perché il nostro score in sala giochi, è inutile negarlo, è sempre stato motivo di grande vanteria. Alla scuderia vennero quindi affiliati “cavalli” di razza, fra cui Steve Meretzky, autore di Planetfall, e Michael Berlyn, responsabile del criticatissimo Infidel. E se il primo titolo mira a commuoverci introducendo Floyd, una spalla robotica a cui sarebbe saggio NON affezionarsi troppo, è con l’opera del secondo che ha inizio la decennale diatriba fra chi sostiene che l’autore debba godere di assoluta libertà artistica e chi, invece, ritiene che questi debba tener conto, sempre e comunque, della soddisfazione personale del giocatore. Infidel (1983) narra la vicenda di un sedicente archeologo, à la Indiana Jones, se vogliamo, alle prese con la ricerca di un favoloso tesoro tumulato in una perduta piramide.
Forti dei primi successi, gli implementatori si resero presto conto della incredibile versatilità dell’interprete realizzato, consapevolezza che li portò a intuire il potenziale che avevano tra le mani, ovvero la possibilità di elevare il medium: in pratica, l’opportunità di raccontare storie al giocatore, vicende in grado di muoverlo al di là della banale logica dell’accumulo di un punteggio – 19 sono i tesori da collezionare nel primo Zork – e della competizione, perché il nostro score in sala giochi, è inutile negarlo, è sempre stato motivo di grande vanteria. Alla scuderia vennero quindi affiliati “cavalli” di razza, fra cui Steve Meretzky, autore di Planetfall, e Michael Berlyn, responsabile del criticatissimo Infidel. E se il primo titolo mira a commuoverci introducendo Floyd, una spalla robotica a cui sarebbe saggio NON affezionarsi troppo, è con l’opera del secondo che ha inizio la decennale diatriba fra chi sostiene che l’autore debba godere di assoluta libertà artistica e chi, invece, ritiene che questi debba tener conto, sempre e comunque, della soddisfazione personale del giocatore. Infidel (1983) narra la vicenda di un sedicente archeologo, à la Indiana Jones, se vogliamo, alle prese con la ricerca di un favoloso tesoro tumulato in una perduta piramide. 





