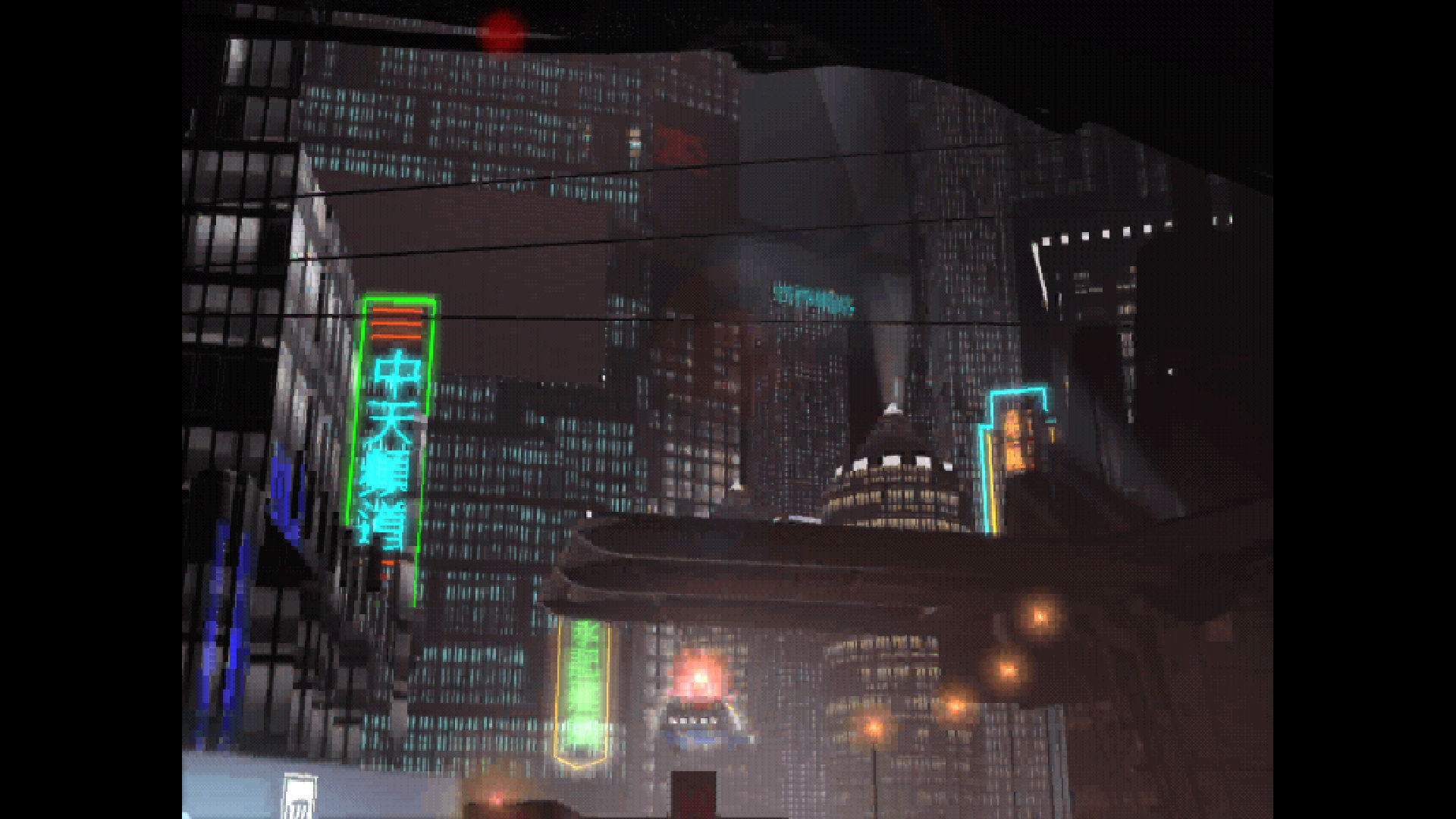La grande avventura – in tutti i sensi – del Blade Runner di Westwood, e quello che voleva dire, ventitre anni fa, andarsene a spasso per il mondo creato da Philip K. Dick e portato sul grande schermo da Ridley Scott.
 Non è successo subito. Blade Runner di Ridley Scott ha impiegato diversi anni per diventare la colonna portante dell’immaginario collettivo che è ormai da tanto tempo. Nell’82, negli anni in cui la fantascienza era per tutti l’adrenalina della saga di Star Wars, il capolavoro neo-noir di Scott è stato stroncato da buona parte della critica. Lo trovavano lento, al punto di coniare quel soprannome che gli è rimasto appiccicato a lungo. “Blade Crawler”. Aveva incassato poco, non arrivando a recuperare del tutto neanche i soldi investiti. Blade Runner sembrava, allora, una pellicola destinata a non lasciare traccia. Dire oggi che non è andata così è, fortunatamente, un eufemismo.
Non è successo subito. Blade Runner di Ridley Scott ha impiegato diversi anni per diventare la colonna portante dell’immaginario collettivo che è ormai da tanto tempo. Nell’82, negli anni in cui la fantascienza era per tutti l’adrenalina della saga di Star Wars, il capolavoro neo-noir di Scott è stato stroncato da buona parte della critica. Lo trovavano lento, al punto di coniare quel soprannome che gli è rimasto appiccicato a lungo. “Blade Crawler”. Aveva incassato poco, non arrivando a recuperare del tutto neanche i soldi investiti. Blade Runner sembrava, allora, una pellicola destinata a non lasciare traccia. Dire oggi che non è andata così è, fortunatamente, un eufemismo.
Non è successo subito: Blade Runner ha impiegato diversi anni per diventare la colonna portante dell’immaginario collettivo che è ormai da tempo
. Continuo a rigirarmi tra le mani il big box del Blade Runner di Westwood Studios.
L’illustrazione sul fronte fa di tutto per far sembrare il protagonista, Ray McCoy, un genuino surrogato di Rick Deckard. Anche se quel volto in CGI appiccicato su una foto ricorda troppo un Del Piero con i capelli corti e il trench. Sul retro,
Rachael, quella matta con gli occhiali neri d
i Crystal Steele,
Lucy con i suoi capelli rosa e la giapponese ingurgita-pillole degli schermi giganti chiudono un patchwork di screen del gioco, sormontato dai dati dell’avventura, snocciolati con fierezza da Westwood.
Quattro CD, 70 personaggi in motion-capture, le voci di diversi membri del cast originale, storia plasmabile in base alle scelte compiute, stralci della colonna sonora del film appositamente ricreati e, soprattutto, la possibilità di usare la
macchina ESPER per analizzare le foto, quella del
test Voight-Kampff per stanare i replicanti, l’auto volante dei piedipiatti dell’
unità Blade Runner, lo Spinner.
Quello che la scatola non dice è che Blade Runner non è un tie-in come tanti, perché riesce nella non semplice impresa di andare oltre il film, creando un ponte con il romanzo originale di Dick e recuperandone diversi elementi. Da grandissimo fan della pellicola e da cultore delle opere dello sfortunato Philip K., di cui proprio in quegli anni da universitario cercavo di recuperare tutto quello che non avevo ancora letto (fratello mio, è andata esattamente così anche per me, ndMario), ce n’era abbastanza per farmi esplodere il cervello. In effetti è quello che è successo.
Blade Runner non è un tie-in come tanti, e anzi crea un ponte con il romanzo originale di Dick recuperandone diversi elementi
. C’era già stato dodici anni prima il
Blade Runner della CRL (Tau Ceti, Bugsy), gioco per
Commodore 64, ZX Spectrum e Amstrad CPC che non era basato in realtà sul film di Scott… ma sulla colonna sonora di
Vangelis, perché quelli erano gli unici diritti che la softco londinese era riuscita a rimediare. “Video game interpretation of the film score”, prometteva la copertina, in un esercizio di arrampicata sugli specchi talmente sfacciato da risultare encomiabile.
Un gioco su un cacciatore di repli…droids, perché è ovviamente di questo che parlavano le musiche del compositore greco, no? Anyway.
Lo scenario, nel 1997, era comunque completamente diverso. “Blade Crawler” si era trasformato in un
capolavoro della fantascienza riconosciuto universalmente come tale. La
Director’s Cut del ’92 non aveva riportato solo
Deckard, Rachael e Roy Batty sul grande schermo, ma piazzato Blade Runner nel posto che gli spettava di diritto,
rinnovandone il culto tra i fan e facendolo scoprire a tanti.
Peraltro, proprio negli anni dell’esplosione multimediale del cyberpunk, della trasformazione di quello che era stato un effimero ma folgorante sottogenere letterario di inizio anni 80 in un filone cinematografico su cui anche il videogioco si sarebbe buttato a pesce, come un determinatissimo James Pond. Erano i tempi del Johnny Mnemonic con Keanu Reeves e di New Rose Hotel, entrambi pescati dai racconti di William Gibson; erano gli anni dell’anime invasion negli USA, capeggiata da film e OAV come Ghost in the Shell e Battle Angel Alita. Non lo sapevamo ancora, ma Matrix era dietro l’angolo.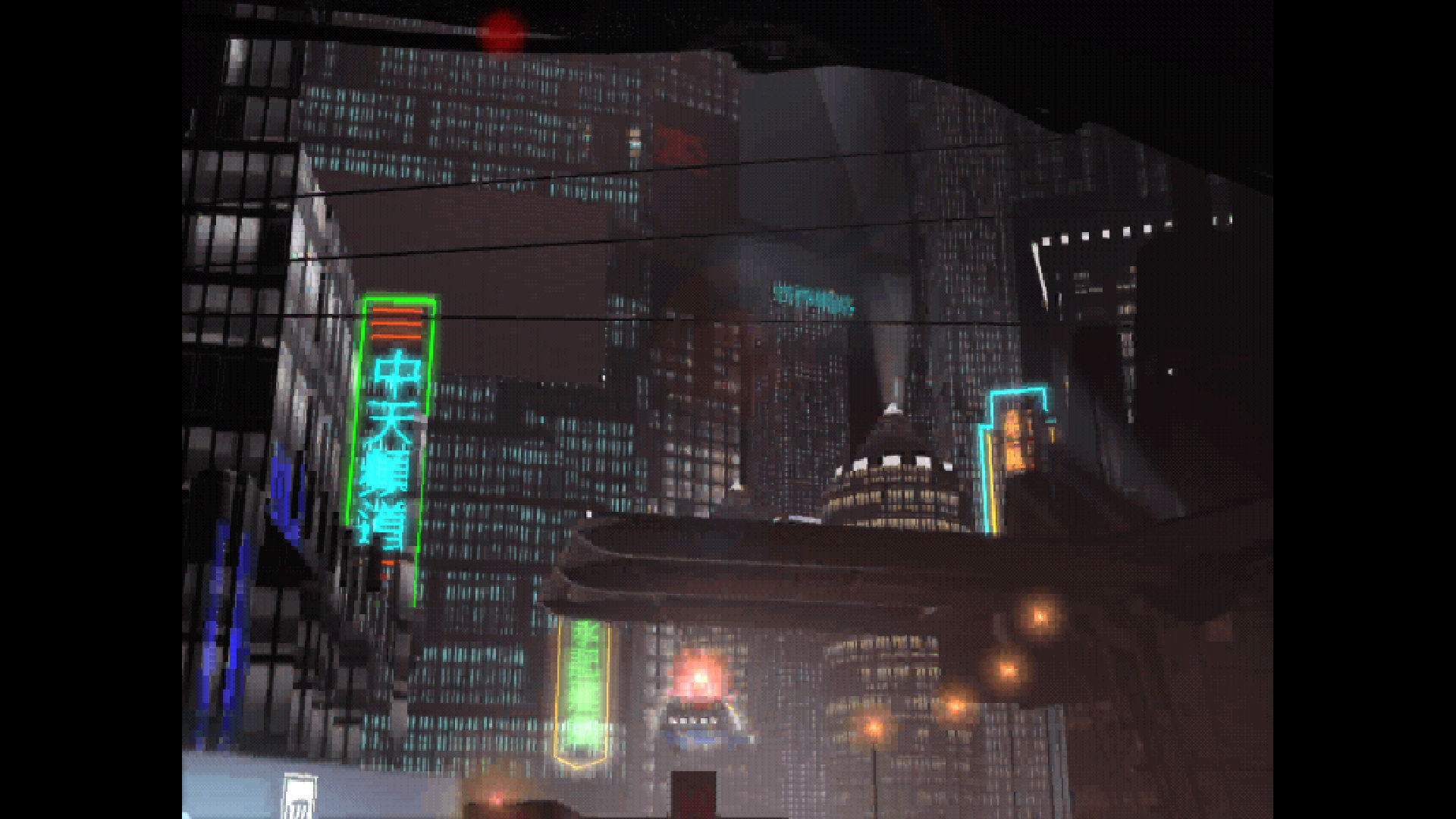
La Director’s Cut non riportò solo Deckard, Rachael e Roy Batty sul grande schermo, ma piazzò anche Blade Runner nel posto che gli spettava
Immersi fino alle orecchie in quel grande,
potentissimo riflusso di immaginario cyberpunk, sognavamo Tokyo e le sue insegne al neon e assorbivamo qualsiasi riflesso di quelle atmosfere ci versassero in retina quegli anni. Trattenendo il fiato ogni singola volta che ci ritrovavamo a volare oltre quel ponte in Gare d’Europa, il più cyberpunk dei
tracciati di Wipeout 2097, con la versione strumentale di
Firestarter dei Prodigy a martellarti le orecchie e farti andare il cuore a mille, fino a sincronizzarlo con quella irrefrenabile voglia di futuro, di nuovo millennio ormai a due passi.
Blade Runner di Westwood arrivò in un momento semplicemente perfetto, per il mood di quei mesi e perché poteva contare su un livello di tecnologia sufficiente per fare quello che aveva intenzione di fare. Portarti a spasso in quel mondo, fin quasi a farti sentire addosso la
pioggia di quella Los Angeles del lontano 2019, grazie a una confezione audiovisiva di assoluto livello.
Per portarti in casa la quale, promette la scatola del gioco, non c’è bisogno di quelle nuove diavolerie, le schede di accelerazione grafica: basta un Pentium 90Mhz con 16 mega di RAM e Windows 95. Ma con un Pentium 133Mhz, ti dice anche, gira meglio.
Continua nella prossima pagina…
 Non è successo subito. Blade Runner di Ridley Scott ha impiegato diversi anni per diventare la colonna portante dell’immaginario collettivo che è ormai da tanto tempo. Nell’82, negli anni in cui la fantascienza era per tutti l’adrenalina della saga di Star Wars, il capolavoro neo-noir di Scott è stato stroncato da buona parte della critica. Lo trovavano lento, al punto di coniare quel soprannome che gli è rimasto appiccicato a lungo. “Blade Crawler”. Aveva incassato poco, non arrivando a recuperare del tutto neanche i soldi investiti. Blade Runner sembrava, allora, una pellicola destinata a non lasciare traccia. Dire oggi che non è andata così è, fortunatamente, un eufemismo.
Non è successo subito. Blade Runner di Ridley Scott ha impiegato diversi anni per diventare la colonna portante dell’immaginario collettivo che è ormai da tanto tempo. Nell’82, negli anni in cui la fantascienza era per tutti l’adrenalina della saga di Star Wars, il capolavoro neo-noir di Scott è stato stroncato da buona parte della critica. Lo trovavano lento, al punto di coniare quel soprannome che gli è rimasto appiccicato a lungo. “Blade Crawler”. Aveva incassato poco, non arrivando a recuperare del tutto neanche i soldi investiti. Blade Runner sembrava, allora, una pellicola destinata a non lasciare traccia. Dire oggi che non è andata così è, fortunatamente, un eufemismo.