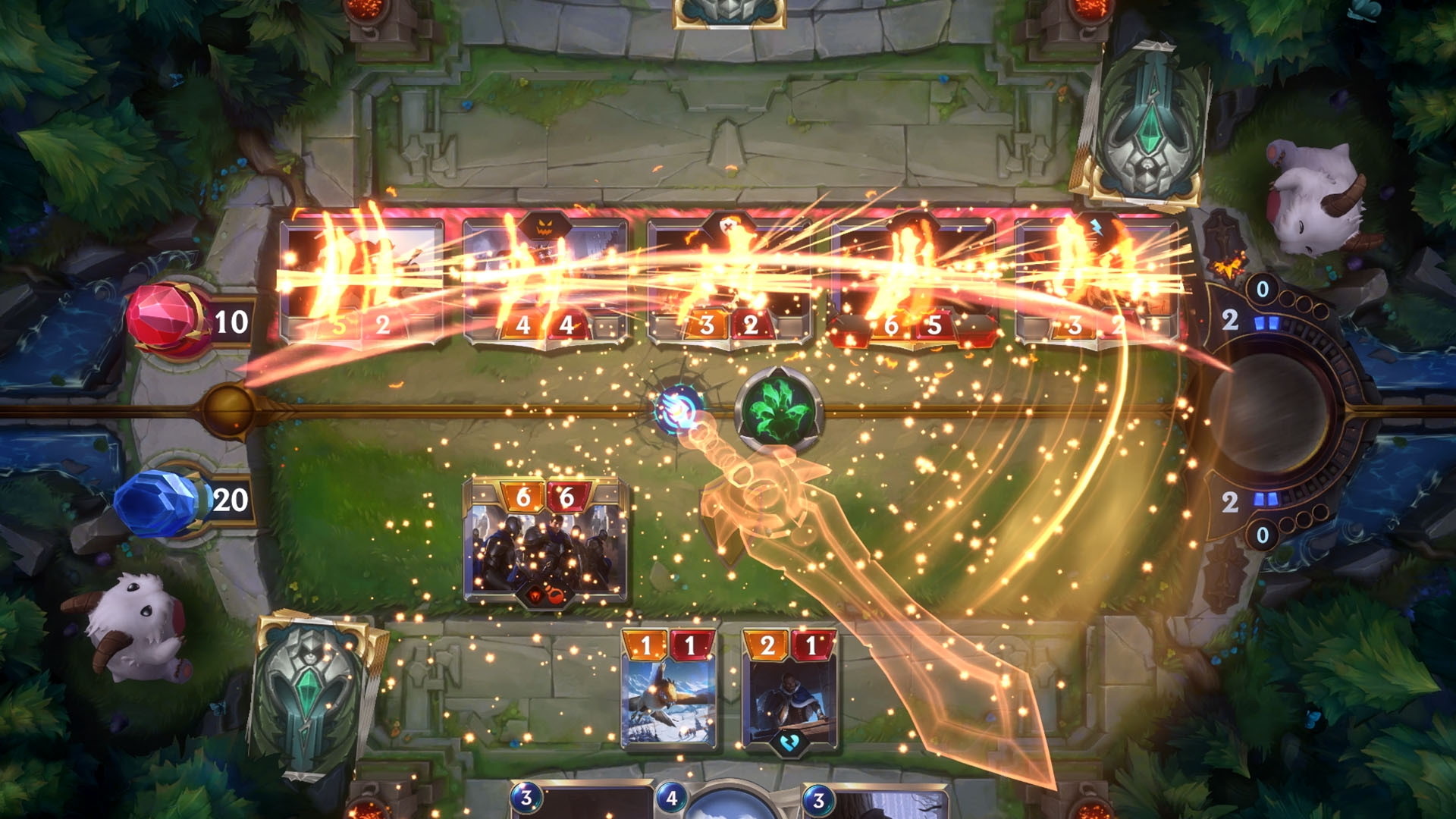C’era una volta una software house che pareva essere stata fondata in California nel 1991 da Re Mida in persona, non da Michael Morhaime, Frank Pearce e Allen Adham. Le sue opere avevano una marcia in più, riuscivano a travalicare i limiti imposti dal termine videogioco quasi a crearle fossero stati degli sviluppatori dotati davvero del tocco magico del leggendario sovrano. L’incredibile passione e la proverbiale cura con cui sfornava pietre miliari dalle sue fucine nei pressi di Irvine erano marchi di fabbrica apprezzati a qualsiasi latitudine e qualsiasi longitudine.
Per chi ci lavorava l’importante era realizzare videogiochi d’una bellezza impareggiabile, più unica che rara come si suole dire. La quantità non aveva alcuna rilevanza tanto è vero che, a costo di realizzarne pochi, non era ammissibile pubblicare un titolo se non raggiungeva una determinata soglia minima di qualità, lo stesso elevato standard che sembrava così arduo da raggiungere per parecchi suoi competitor. L’avete riconosciuta?
IL FATTORE BLIZZARD
Parlo di Blizzard Entertainment, proprio la musa videoludica a cui un’infinità di noi ha giurato fede eterna. Non posso sbilanciarmi a nome di tutti eppure so di non essere l’unico legato sentimentalmente ai capolavori della software house americana. Del resto Warcraft, StarCraft e Diablo hanno contribuito allo sviluppo del medium che ci unisce, sono franchise riconosciuti universalmente come frammenti di storia del videoludo destinati a vivere in eterno. Tutti noi sappiamo, per esperienza diretta o per sentito dire, che il fattore Blizzard era qualcosa di speciale, chiunque bazzichi il mondo dei videogiochi da più di una manciata di anni molto probabilmente ha tra i suoi titoli preferiti di sempre almeno un prodotto targato Blizzard.
Tralasciando il mio legame affettivo con World of Warcraft o Diablo, c’è un preciso giorno che ricordo come fosse ieri: mi riferisco al momento esatto in cui rimasi folgorato dall’incredibile spettacolo in CGI d’epoca che prendeva vita sul mio primo PC (se non sbaglio un grigissimo 486 della Packard Bell). Non so quante volte ho sognato a occhi aperti mentre ammiravo affascinato i vermigli vessilli dell’Orda, il mare e il cielo sferzati dalla brama di sangue degli orchi, le mura degli uomini prese d’assalto dall’agitazione e le forze dell’Alleanza intente a prepararsi per dare il benvenuto ai nemici portati dalle onde. Riflettendoci su adesso, a distanza di circa venticinque anni, m’accorgo che noi gamer sperimentiamo l’amore vero ben prima degli altri e forse è anche per questo che ad alcuni di noi il presente fa più male rispetto ad altri.
BRICIOLE DI GLORIA IMPERITURA
C’è adesso una software house in difficoltà su più fronti e non solo a causa della situazione pandemica globale, anzi direi che nei tormenti di Blizzard non c’entra, al massimo è un’attenuante valida per giustificare alcuni rinvii. Il polverone sollevato dallo scandalo molestie, le conseguenti beghe giudiziarie (le indagini sono ancora in corso) e i numerosi risvolti che inevitabilmente hanno incrinato gli equilibri della società e la sua immagine sono solamente la punta di un iceberg di cui qualcuno sospettava l’esistenza da un po’, diciamocelo.
BLIZZARD SI TROVA AL MOMENTO IN DIFFICOLTÀ SU PIÙ FRONTI, E NON SOLO PER LA SITUAZIONE PANDEMICA, FRA REMASTER POCO FORTUNATE E PROBLEMI INTERNI NON TRASCURABILI
BLASFEMIA O PROFEZIA?
Ecco, è proprio qui che desideravo condurvi, nel punto in cui si deve abbandonare la terra ferma della realtà per navigare tra gli inesplicabili flutti di un mare d’ipotesi. Al di là di ogni speculazione, oltre le opinioni più audaci e superati i nebulosi scogli del futuro, forse ad attenderci fra qualche tempo ci sarà una scena videoludica senza Blizzard (o con una Blizzard non più tanto… Blizzard, ecco) meno triste di quella che ci saremmo potuti figurare fino ad alcuni anni fa. A fine gennaio 2020 il nostro coraggioso – o folle, fate vobis – Mario mi diede l’opportunità di partecipare all’anteprima mondiale di Valorant presso gli studi di Riot Games a Santa Monica (LA). Durante un momento di osservazione passiva dello shooter online a quel tempo avvolto dal mistero, mentre ero impegnato a vivisezionarlo cercando al contempo di dare l’impressione al resto dei presenti di essere stoicamente insensibile al jet lag, una frase detta da un collega mi colpì: “Riot vuole diventare la nuova Blizzard”.
Proprio qualche giorno addietro mi è tornata prepotentemente in mente quell’esclamazione ai limiti della blasfemia per ogni fanatico d.o.c. di Blizzard, quella sensazione buttata lì tra uno sbadiglio e un headshot. Niente di strano, ci sta ripensare a quelle parole adesso, Riot Games è una delle software house più chiacchierate del momento grazie allo straripante successo riscosso da Arcane, la serie animata disponibile su Netflix ispirata al lore di League of Legends, oppure all’apprezzato Ruined King: A League of Legends Story, un RPG a turni anch’esso tratto da League of Legends (a onor del vero realizzato però dall’artista Joe Madureira e il suo Airship Syndicate, lo studio responsabile di Battle Chasers: Nightwar). Tornando a quelle parole mi sono ricordato che, a suo tempo, l’universo Riot Games mi fece un’impressione pazzesca per una lunga serie di motivi. Al di là della convincente performance di Valorant nonostante stessimo testando una build decisamente work in progress (talmente provvisoria che veniva aggiornata dai dev tra un test e l’altro), percepire sulla mia pelle tutta l’energia e la passione che animava ogni membro dello staff Riot fu così forte da farmi rientrare in Italia con una convinzione marmorea: Riot Games ambisce a essere la numero uno in tutto ciò che fa.
QUELLA DI RIOT GAMES È SICUREZZA DI SÈ
Il suo slogan dice “We don’t make games. We make Riots”, un motto alquanto indicativo circa le intenzioni della software house californiana fondata nel 2006 a Los Angeles da Brandon Beck e Marc Merrill. A distanza di tempo da quei giorni negli USA mi rendo conto che tutto ciò a cui ho assistito era autentico, non si trattava solamente di dover dare a qualsiasi costo un’immagine positiva di sé alla stampa; era vera la granitica determinazione di Anna Donlon durante le interviste, lo era il contagioso entusiasmo degli sviluppatori mentre spiegavano ogni feature di Valorant e lo era la diffusa sicurezza nei propri mezzi che permeava ogni anfratto degli studios.
Riot Games ha intenzione di essere ricordata dai gamer del futuro non soltanto per il suo MOBA, la voglia di stupire e la poderosa sensazione di “potenza aziendale” che ho respirato in quel press tour oltreoceano sembravano quasi tangibili allora e lo sono allo stesso modo oggi, senza dimenticare che in quegli studi e in quelle menti ci sono progetti e bozze concettuali di cui non sappiamo ancora nulla, quindi sono più che sicuro che in futuro ne vedremo delle belle.
RUNETERRA è UN UNIVERSO NARRATIVO TROPPO AFFASCINANTE PER NON ESSERE SFRUTTATO
Come ho avuto modo di scoprire dal vivo, Riot Games cura in modo maniacale non solo l’essenza del gameplay dei suoi giochi ma anche tutti quegli aspetti che contribuiscono a fare sentire coccolati i giocatori come la salute delle infrastrutture online, la risonanza mediatica dei tornei che organizza o la visibilità garantita dagli eventi mondiali, la lotta ai cheater e il benessere della comunità sulla base dei feedback (peccato che la comunità di League of Legends sia una delle più tossiche che ci sia, ma questa è un’altra storia).
RIOT SEMBRA IN GRADO DI DIRE LA SUA IN QUALSIASI CAMPO SCELGA DI DEDICARSI
Checché se ne pensi della società in sé (per dovere di cronaca va detto che anche Riot Games a inizio anno è stata coinvolta in un presunto scandalo di molestie sul lavoro da parte del CEO Nicolo Laurent, ma le indagini si sono chiuse con un nulla di fatto per mancanza di prove), è lapalissiano che Riot Games abbia talento, risorse, idee e passione, tutte peculiarità a cui non bisogna scordare di aggiungere l’ambizione di essere la numero uno e le potenzialità per riuscirci. Riallacciando il filo del discorso alla frase proferita dal collega negli studi Riot Games di Santa Monica una mattina di gennaio, tenendo presenti le dovute differenze fra le software house protagoniste dell’editoriale testé letto e ripensando ai percorsi affrontati dai due colossi californiani nel corso degli ultimi anni, una domanda volutamente provocatoria mi sorge spontanea e, a pensarci bene, è proprio il quesito ideale per congedarmi da voi: quel “Riot Games vuole diventare la nuova Blizzard” fu blasfemia o profezia?