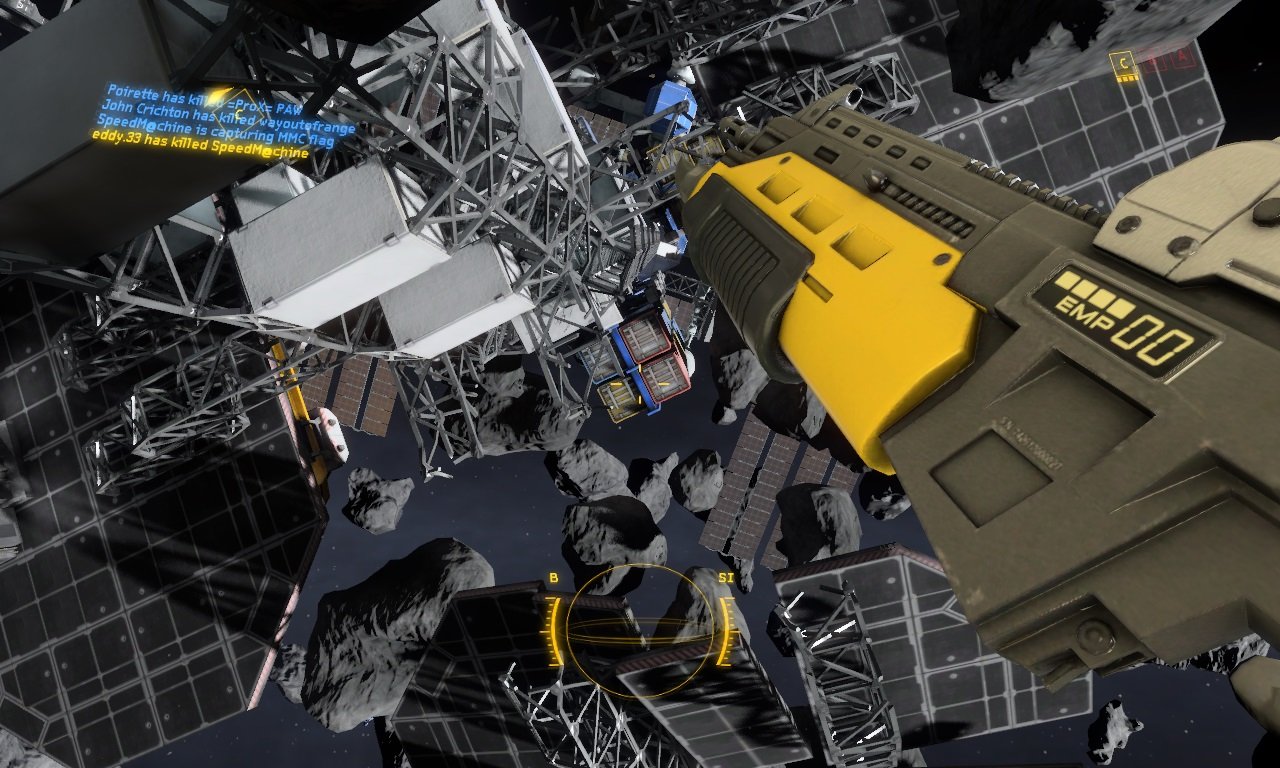Nei meandri del cervello di tanti giocatori, assopito o vigile a seconda del caso, si nasconde un game designer. Così come i sogni da regista possono percorrere i neuroni degli appassionati di cinema, facendo lampeggiare l’emisfero sinistro, è normale che i fruitori assidui di videogiochi, specialmente i veterani, abbiamo prima o poi fantasticato una o più opere create a loro immagine, mischiando le proprie esperienze con la libertà di chi non deve per forza realizzare qualcosa di concreto. E tutte le volte che un ragazzino (amichetti dei miei figli, o figli di amici che hanno saputo del mio lavoro) mi chiede cosa sia necessario fare per avviarsi alla mia professione, rispondo che il giornalismo videoludico italiano ha già abbastanza mano d’opera: i miti dei redattori di videogiochi sono stati già creati e ricreati, mentre altre realtà nel mondo si impegnavano in qualcosa di ben più lungimirante e proficuo.
Occorre che siano fornite al game designer le chiavi per uscire dal cervello
SOGNI BAGNATI DI UN VIDEOGIOCATORE
Per quel che mi riguarda, i miei ricordi di piccolo game designer si perdono in un’epoca molto diversa, oltre che in un luogo economicamente condannato all’immobilismo. Può sembrare auto-indulgente, ma le possibilità che un ragazzino di Carrara diventasse uno sviluppatore di videogiochi erano molto prossime allo zero. Prima di procedere, però, è bene che specifichi di non essere uno di quei matti sempre pronti a far causa a qualcuno: nel 1984 persino i membri del Team 17 erano ragazzini, e certo non avevano la più pallida idea che un bambino italiano ai piedi delle montagne di marmo avesse pensato a qualcosa di molto simile ad Alien Breed. La faccenda era questa: io, da sempre intrippato nel disegno, avevo tracciato uno schema bidimensionale palesemente ispirato ad Alien, con nemici identici allo xenomorfo e una serie di intricati labirinti; mio fratello, allora sedicenne, aveva cominciato ad occuparsi della programmazione scrivendo in Basic (ahah, che teneri) sul nostro Spectrum 48K. L’arma era solo il lanciafiamme, per la verità, e d’altronde l’ambizioso progetto è rimasto un gioco nel gioco di due bambini che si volevano – e si vogliono, ancora bambini dentro – un gran bene. Da quel momento ho creato uno dei miei personali universi alternativi, in cui i “Baccigalupi Brothers” non sono un giornalista e un cosmologo (chapeau), ma due affiatatissimi game designer di successo. In fin dei conti, per far concretizzare il sogno, sarebbe bastato spostare la location creativa di 10.000 chilometri…
Le possibilità che un ragazzino di Carrara diventasse uno sviluppatore di videogiochi erano molto prossime allo zero
Un altro gioco, infine, abbisognerebbe di una vera corazzata produttiva. L’astronave di un piccolo ma evolutissimo alieno entra in avaria nelle vicinanze della Terra, e il microscopico visitatore deve scendere sul pianeta e organizzarsi; con fare immensamente più machiavellico di E.T., il nostro eroe può controllare i corpi umani come fossero robot, ed ha come obiettivi intermedio e finale quelli di costruirsi un animatrone robotico ben più prestante di un essere umano, e ovviamente di approntare una nuova astronave (la sua è esplosa dopo il brusco atterraggio) per tornare a casa. Per il setting ho immaginato un free roaming urbano leggero nella grafica e vissuto in una doppia scala, con i velivoli del minuscolo alieno e, una volta agganciato un ospite (per le orecchie o anche peggio, a seconda del coraggio produttivo), con le consuetudini di un “normale” action adventure. E se qualcuno ha intravisto una vaga ispirazione a Messiah, ha centrato in pieno il bersaglio.
Nel 1982 ho sperato di poter giocare in prima persona in una cupa metropoli del vicino futuro